LA MEMORIA OBLIQUA DI CAVAGLION: TRA TERRE CRETACEE, TORRI E AQUILONI.
Nel 79 d.C., mentre la furia del Vesuvio spazzava via i popolosi abitati di Pompei, Ercolano e Stabia, nella corrispondenza epistolare con l’amico Tacito, Plinio il Giovane scriveva: «Agli sguardi ancor tremanti, tutto si mostrava cambiato».
E cambiato appare il comune sentire, il paesaggio, la
memoria stessa dopo l’eccidio perpetrato dalla follia nazista a danno del
popolo ebraico (e non solo). Un ignominioso blackout dell’umanità che viene
sempre più spesso vissuto come un semplice momento commemorativo da imprimere a
fuoco nelle menti prima ancora che negli spiriti delle generazioni che si sono
avvicendate nel corso degli anni.
Soprattutto in Europa, si ergono continuamente monumenti, si
inaugurano luoghi della memoria, si appongono sul suolo pietre d’inciampo.
Ma nei nuovi tempi moderni (anche alla luce di ciò che negli ultimi giorni sta accadendo in Medioriente), in cui è palese e tangibile la
riemersione di tensioni discriminatorie, tutto ciò può essere sufficiente? Può
bastare il continuo e vuoto formalismo del ricordare?
Questi sono gli interrogativi principali a cui il prof. Cavaglion
tenta di rispondere in maniera esaustiva nel suo saggio critico, Decontaminare le
memorie. Luoghi, libri, sogni, edito da ADD.
Nella sua analisi, l’autore parte anzitutto da una breve
descrizione ambientale dalla quale trae spunto l’opera: «Modena e il mondo rurale
circostante» e cita alcuni dei maggiori intellettuali del XX secolo, quali
Arturo Loria, Primo Levi e molti altri. Attenzione particolare riserva al lavoro
dell’illuminato editore Angelo Fortunato Formiggini suicidatosi gettandosi nello
spiazzale antistante la torre della Ghirlandina di Modena (Al tvajol ed Furmajin, come
egli stesso chiese di definire il luogo) all’indomani della ratifica delle
leggi raziali.
Proprio prendendo le mosse dal pensiero del Formiggini e dalla sua rivoluzionaria idea della Casa del Ridere (museo poi irrealizzato), Cavaglion incentra il proprio narrare su una letteratura che possiamo definire collaterale.
In altre parole, essa non deve limitarsi a conservare i
libri relativi alla memoria su scaffali impolverati, ma ve ne deve affiancare di nuovi
e all’apparenza innovativi che il Male lo ricordino in altro verso, lo
richiamino direttamente o indirettamente, lo evochino in termini diversi. È
indispensabile che tale improcrastinabile confronto inviti a quella riflessione
critica che in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, sembra piegata dall’evidente
declino culturale delle giovani menti, dai messaggi distorti lanciati da
programmi politici che sviliscono la cultura, da una memoria che rischia di
rimanere impressa soltanto sulla carta e che, per citare Saul Bellow, non riesce
più a tenere «il lupo dell’insignificanza fuori dalla porta».
Per l’autore cuneese anche l’ironia, l’allegria simposiale,
il sarcasmo potrebbero rivelarsi ottimi antidoti per la risoluzione della
problematica della memoria perché essa «non può reggersi soltanto sul pianto o
sul lutto», ma è fondamentale che «dalla tragedia nasca la voglia di vivere».
Quando «la memoria non conosceva abusi», gli intellettuali ebrei solevano prendere ispirazione per le loro opere dai territori (non sempre salubri) di Mantova, Modena, Fossoli, Carpi, Ferrara e ricchissima fu, infatti, la produzione letteraria dei primi del Novecento. Ammaliati dalla calda accoglienza del Belpaese, pochi prestarono attenzione alle tormentate vicende politiche italiane e, d’improvviso, vennero travolti dalle conseguenze nefaste che ne scaturirono come se si fossero ritrovati immoti spettatori della piena del Po del 1836. Non potevano figurarsi ciò che sarebbe successo più avanti e sottovalutarono il preciso istante in cui «il paesaggio della memoria» iniziò drasticamente a mutare sotto le feroci spinte del totalitarismo (italiano e tedesco) che avrebbe insanguinato negli anni successivi quelle terre una volta amène e serenissime.
E così, gli scritti agresti intrisi di pace e visioni
bucoliche di Cantoni, Loria, Massarani e Formiggini stesso si contrappongono a
quelli luttuosi di Giorgio Bassani, ai cimiteri, ai mausolei, alle tombe che
diventano «metafora della speranza perduta» di godere della libertà del bello.
Per Cavaglion la “questione” memoria presenta dei problemi
di fondo: banalizzazione, sacralizzazione, commercializzazione. Con l’intento
di ricordare gli scempi del passato, si è ricorsi ad una memoria “sbagliata”
che lentamente si è svuotata del proprio contenuto e si è conformata alla
società, intanto che, in un processo di diretta proporzionalità, lo stesso
indotto sociale si conformava alla memoria.
Prendendo spunto da questa riflessione, Cavaglion indica la possibilità
di fare ricorso alla “memoria obliqua”, già teorizzata dal francese Georges
Perec. Si tratta di una memoria intima, sensibile, scevra dalle liturgie
commerciali, dai sensazionalismi istituzionali, basata sull’assunto «per capire
si deve rimpicciolire, non ingrandire». Difatti, sono le piccole cose dalle
quali bisogna partire per costruire e ricostruire ancora, per comprendere certi
sottili significati poiché, richiamando Georges Bernanos: «Le cose piccole
hanno l’aria di nulla ma danno la pace».
Si tratta di un espediente utilizzato furbescamente per non
cadere nella trappola del banale che a nient'altro può servire se non ad allontanare
il problema dalle nostre coscienze, a lavarlo con la fluidità nebulosa del
futuro.
In quello stesso momento storico, si afferma la cosiddetta “filosofia
del ciononostante”: chi è sopravvissuto alla tragedia dello sterminio tenta in
qualche maniera di raccontare la propria esperienza ad altri, di tramandarla se
si vuole, attraverso lettere, disegni. Eppure, di tutto quel materiale
dall’enorme potenziale salvifico, pochissime sono le tracce giunte sino a noi: colpa
indelebile, se si riflette sul valore andato smarrito tra le increspature del
tempo. I sopravvissuti sono stati dapprima testimoni eloquentemente muti di
qualcosa che in origine si è tentato persino di rinnegare, di cancellare dagli
archivi mnemonici della storia. In un momento successivo, sono divenuti maestri
di resilienza, incrollabili nella loro fede, nel loro comune sentire. Maestri
di vita e morte assieme, tra i quali capeggia certamente Primo Levi, il quale
decise scientemente di togliersi la vita, dopo che i nazisti vi attentarono più
volte.
Il discorso sulla Shoah è senza dubbio più complesso di quello che si riduce alle celebrazioni annuali del Giorno della Memoria: è fatto di volti e nomi (centinaia di migliaia), di testi noti e meno noti, di voci che si stanno spegnendo incalzati dalla fugacità dell’esistenza terrena, di luoghi sui quali è posto lo stigma del Male che non sono mai veramente come appaiono e devono essere prudentemente decontaminati. Ciò è riscontrabile non solo nelle lande padane, ma anche in quelle del Meridione, a Torino così come a Mantova, a Roma così come a Fossoli. Si tratta di luoghi “contaminati”, “avvelenati dal male” che non possono essere attraversati come fossero delle mete turistiche, ma richiedono di sostare sulle soglie e di meditare su ciò che si è consumato sui loro suoli.
Altro passaggio degno di nota è il collegamento, a
mio avviso magistrale, che l’autore crea tra due frontiere, un ponte, uno
stadio e la scuola.
Quanto alle prime, Cavaglion invita il lettore a riflettere
sul ruolo svolto dalle stazioni ferroviarie, zone di «separazione, partenze
coatte, convogli di deportati, di esilio e fuga». Sollecita ad analizzare il
paesaggio interstiziale della stazione transalpina di Gorizia: è proprio qui,
secondo lui, che si è avviato un lento, ma importantissimo processo di
decontaminazione che vedrà riunite nel 2025, sotto il vessillo di città della
cultura, due centri a lungo divisi dalle ideologie politiche quali Gorizia e
Nuova Gorica. Stesso processo purificatore non può dirsi avviato, invece, per
altre realtà come quelle francesi o quelle liguri (cita Ventimiglia) i cui
confini quotidianamente respingono con rabbia esuli e fuggiaschi. E mi vien da
dire, forse azzardando, non è olocausto anche quello, seppure perpetrato in
tempi nuovi e con modalità differenti?
Il secondo punto d’osservazione si concentra sul ponte
Morandi, o per meglio dire, su ciò che di esso rimane: rovine e macerie che la
natura sta facendo proprie, sta tentando appunto di decontaminare dall’incuria
umana cagione del disastro. Così come lo stadio Filadelfia del capoluogo
piemontese, anni addietro tempio delle più acclamate sfide calcistiche, oggi in
decadimento e sempre più di frequente associato alla tragedia della squadra del
grande Torino del compianto Valentino Mazzola.
Infine, il luogo prediletto: la scuola. Una scuola “malata”
a dire di Cavaglion, nella quale trova spazio la burocrazia a danno
dell’immaginazione, il rigido rispetto degli schemi dei programmi a danno della
libertà, nella quale gli allievi non vengono educati alla cultura della
speranza, ma a quella del dramma e dell’orrore.
La terza e ultima parte dell’opera è la più profonda e
personale ed è quella che svela ciò che è presente nell’intimità dell’autore: i
suoi vagheggi onirici, le sue abitudini, le sue speranze, la preoccupazione per
il virus pandemico che per due anni ci ha assediati e resi schiavi delle nostre
case, le aspettative sul futuro.
Decontaminare le memorie è un testo “sentinella” anche un
po' scomodo, se volete. Scomodo nella misura in cui porta ad analizzare il tema
spinoso della conservazione e tutela della memoria dell’Olocausto da una differente
angolazione: non è semplicisticamente una questione etica di schieramenti (chi
è “buono”, chi è “cattivo”), bensì si tratta di individuare quali sono state le
cause generatrici di quella follia e quali gli errori compiuti dalla storia e
da noi stessi che della storia siamo parte attiva e integrante.
Ciò che colpisce del saggio è l’affezione viscerale dell’autore
verso le opere letterarie e verso il messaggio in esse contenuto. Cavaglion ne riporta
moltissime, ne diventa quasi un custode accorto, silente e consapevole. Con
garbo e pacatezza esprime un monito di ribellione e protesta verso un sistema
istituzionale che brancola nella cecità dell’oscurantismo culturale quando fa
propria l’affermazione di Enrico Heine «chi brucia libri finisce col bruciare
uomini, la violenza è un seme che non si estingue».
Se gli intellettuali del primo Novecento sono stati distratti
dalla falsa promessa di bellezza e serenità di una Nazione forte, uscita
vittoriosa dal primo conflitto mondiale, le menti delle generazioni moderne
sono ottenebrate dall’uso smodato della tecnologia (talvolta poco utile, a
tratti persino dannosa) e da un benessere incontrollato.
Dunque, diviene indispensabile interpretare gli abomini del
passato in altro modo per far sì che la Storia dialoghi fattivamente col
presente e ciò con l’unico scopo di garantire che l’accorata preghiera di Primo
Levi (ciò che è stato non si ripeta mai più) non venga decontestualizzata, strumentalizzata
politicamente a piacimento di questo o quello schieramento, ma sia ascoltata ed
esaudita.
Le parole dei testimoni della memoria devono scavare nell’animo
seguendo l’aforisma ovidiano «come molle acqua che scava la dura pietra»,
devono discendere in profondità, intaccare anche i cuori più imperturbabili.
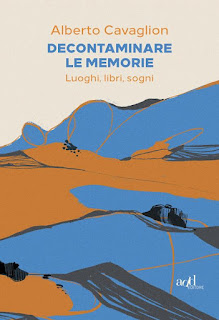



Commenti
Posta un commento