UN QUADRIFOGLIO, VERDE TRA LE SPINE: IL MIRABILE LAVORO DI ETTORE MARINO
Non nutro dubbio alcuno (né potrei nutrirne), sul fatto che Ettore Marino faccia parte delle schiere angeliche (non mi si accusi di blasfemia per l’ardito paragone!) delle penne calabresi più dotte che compongono il panorama culturale attuale. Tanto per la resilienza che dimostra nell’occuparsi di cultura in una terra sempre più ostile e sterile, tanto per la preziosità di contenuti e di forma delle sue opere.
I suoi scritti sono dotati di un fascino e di una padronanza linguistica senza pari: sono al tempo stesso illuminati e sapientissimi, ma anche fruibili per una vasta cerchia di potenziali lettori. Le caratteristiche sopra esposte non mancano di impreziosire il volume che qui, con estrema umiltà, mi appresto a descrivere: Un Quadrifoglio, verde tra le spine, edito da Rubbettino.
Si tratta di una coraggiosa trasposizione in italiano di alcuni passi di quattro importantissimi autori italo-albanesi (da qui la denominazione Quadrifoglio): Gerolamo De Rada, Giuseppe Serembe, Francesco Antonio Santori e Giuseppe Schirò.
Il volume si articola inizialmente in un’accorta e consapevole disamina dello stato attuale delle cose che connota una lingua, l’arbëreshe, per la quale il Marino palesa il proprio amore incondizionato. Tale lingua non è dialetto locale, ma è idioma di popolo e memoria di storia antica narrata dagli avi e che, ahimé, con l’avvento delle nuove generazioni, spesso disinteressate ed attirate da vaghi echi di sirene lontanissime, rischia di andar perduta per sempre.
L’autore già dalle prime pagine punta dritto al nocciolo della questione; non si nasconde; non ci gira attorno; si duole tristemente per qualcosa che appare ovvio: "Perché muore la arbërishte? Sporade di dialetti più che lingua; povera e perciò adatta solo alla comunicazione spicciola; letta soltanto da chi l’ama; meticcia fin oltre il grottesco; irrigidita in bocca ai vecchi; estranea o impaccio ai giovani; inetta a rinnovarsi; inutile al mondo della vita, era fatale che vanisse".
Eppure belli (anzi bellissimi) sono i versi di cui Ettore Marino si è fatto mirabilmente traduttore.
Delicati, quasi mistici, forse perché influenzati dalla sua umile carriera ecclesiale, sono quelli di Santori: "Scrissi per rabbia, scrissi per amore, / io, che d’amore il fuoco non sfiorai./ Io che cieco trascorsi le mie ore/ scrivo ciò di cui lessi – e tu lo sai […]" (F. A. Santori, Il Canzoniere albanese, Proemio).
 |
| Giuseppe Serembe |
 |
| Giuseppe Schirò |
Il meticoloso lavoro compiuto dall’autore merita vigile attenzione e profondo rispetto. La prima, per l'audace perseveranza nel perpetrare ai più ciò che rischia di rimanere in possesso di pochissimi (di nessuno, probabilmente). Il secondo, per il titanico sforzo dell’individuare un fil rouge atto a connettere quattro affascinanti figure poetiche diversissime tra loro per stili e contenuti.
Ettore Marino è cantore solitario e nervoso d’altri tempi: sebbene abbia apparentemente circoscritto la sua attività ad un lavoro di mera traduzione dalla lingua arbëreshe a quella italiana, non manca di esibirne con la disinvolta grazia delle proprie parole, un’utilità indiscussa in un contesto socio-culturale-antropologico in cui ogni cosa tende sempre più a sfumare, come fosse vapore sulle lastre delle finestre in gennaio.
Candide esattamente come la copertina del libro, alcune parole a fil di nota riassumono tutta la purezza del suo impegno produttivo: "L’autore è tale se c’è l’opera. Quello morrà, questa rimane. Perciò soltanto è sacra. Perciò non va sporcata. Parla essa sola".
Ilina Sancineti
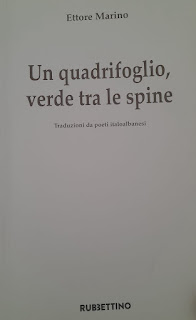

Commenti
Posta un commento